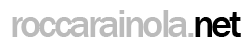Il debutto sulla Rai della fiction Leopardi: il poeta dell’infinito ha riacceso l’interesse sul grande poeta e in particolare sulla morte di Giacomo Leopardi. La stessa impostazione narrativa della miniserie, che parte dalla morte stessa per ricostruirne la vita e i traguardi poetici, riporta a galla uno degli aspetti più intriganti e dibattuti della sua biografia. La morte dello scrittore e intellettuale, avvenuta il 14 giugno 1837 a pochi giorni dal suo 39esimo compleanno, non fu una grande sorpresa date le sue condizioni di salute da sempre cagionevoli ma colpì nonostante tutto per il suo accadere così precocemente. E in ogni caso molti dibattiti, ipotesi e ricostruzioni si sono fatti nel corso del tempo su come sia avvenuto il decesso stesso, su quali siano state le case e l’effettivo succedersi degli eventi.
Dopo aver trascorso diversi anni tra Roma e Firenze, nel 1833 Leopardi decise di recarsi a Napoli con Antonio Ranieri, patriota e scrittore con il quale il poeta aveva intrecciato un’amicizia molto intensa e una fitta corrispondenza carica di parole appassionate (tanto che secondo alcuni il loro rapporto sarebbe stato anche di natura amorosa, anche se probabilmente solo in maniera platonica). Furono anni segnati da ulteriori problemi di salute (nonché dalla censura delle Operette morali da parte dei Borboni) e allo scoppiare di un’epidemia di colera nel 1836, Leopardi, Ranieri e la sorella di quest’ultimo ripararono a Torre del Greco. Nonostante la sua salute cagionevole, si dice che in quel periodo Leopardi conducesse una vita sregolata, scrivendo senza sosta e senza riposo (scrisse in questo periodo la famosa La ginestra), concedendosi parecchi dolci, sorbetti e caffé, e frequentando luoghi affollati come le mense pubbliche.
Tornato a Napoli nel febbraio 1837, le sue condizioni continuavano a peggiorare. Secondo le ricostruzioni il 14 giugno di quell’anno, Leopardi ebbe un malore dopo un lauto pranzo (che consumava come sua abitudine nel tardo pomeriggio, e che in quell’occasione era consistito in un chilo e mezzo di confetti, una cioccolata, una minestra e una limonata o granita). L’idea era quella di partire presto per Villa Carafa d’Andria Ferrigni, oggi Villa delle Ginestre nella frazione Leopardi di Torre del Greco, ma la sua asma peggiorò all’improvviso tanto da portarlo alla morte probabilmente attorno alle ore 21, tra le braccia di Ranieri: “ciao, Totonno, non veggo più luce”, sarebbero state le sue ultime parole.
La morte di Leopardi raccontata nell’opera di Antonio Ranieri
Lo stesso Ranieri indicò la causa della morte in una “idropisia di cuore”, ovvero una idropisia polmorare o idropericardio (l’accumulo ossia di liquidi nel torace e nei polmoni). Fu l’amico a scrivere un necrologio tre giorni dopo sul giornate Il Progresso, per poi pubblicare nel 1880 Sette anni di sodalizio con Giacomo Leopardi, in cui ricostruiva i suoi anni vicino al poeta: quest’opera fu molto criticata negli anni successivi per aver rivelato fatti intimi di Leopardi (descritto spesso in modo sferzante come un ingordo e un ipocondriaco) ma soprattutto per le ricostruzioni tendenziose, come quella che Ranieri lo avesse mantenuto in quegli ultimi anni, mentre documenti emersi nel frattempo hanno dimostrato che fu esattamente il contrario (Leopardi ossia aveva mantenuto Ranieri e la sorella nonostante la magra pensione ricevuta dalla famiglia). Le testimonianze di Ranieri sono dunque in generale ritenute inaffidabili e molti hanno anche messo in dubbio la ricostruzione della morte: altri studiosi hanno avanzato ipotesi differenti, come pericardite, coma diabetico, congestione o indigestione, fino al colera stesso.
C’è addirittura chi dice che la morte di Giacomo Leopardi non fosse avvenuta a Napoli, in vico Pero 2 dove i documenti ufficiali attestano il suo decesso, ma a bordo di una carrozza diretta a Castellamare di Stabia dove si stava recando per delle cure termali. L’indirizzo sarebbe stato cambiato per eludere che il corpo del poeta fosse gettato in una fossa comune, come avrebbe dettato la severa legge del tempo in fatto di epidemie. Nonostante le accuse di attendibilità, pare fosse stato proprio Antonio Ranieri in ogni caso a garantire una degna sepoltura al grande scrittore: rivolgendosi alle sue conoscenze (come il marchese di Pietracatella e Francesco Saverio del Carretto, rispettivamente ex ministro degli Interni e ministro della Polizia del Regno di Napoli), ottenne una deroga, forse anche corrompendo qualche ufficiale, e le spoglie furono inumate prima nella cripta e poi nell’ingresso della chiesa di San Vitale Martire (oggi Chiesa del Buon Pastore).
Da qui parte l’ulteriore mistero sui suoi resti: si sostenne infatti che Ranieri avesse mentito e compiuto un funerale a barra vuota e che Leopardi fosse stato invece effettivamente buttato in una fossa comune al Cimitero delle Fontanelle; un’esumazione ufficiale nel 1900 finì tra mille dubbi per confermare che quelli di San Vitale Martire fossero comunque i resti del poeta, nonostante mancassero cranio e gran parte dello scheletro (mentre nella piccola bara venne rinvenuta una scarpa col tacco). Nonostante ulteriori tentativi di spostare la salma a Recanati o Firenze, nel 1939 Mussolini acconsentì un’ulteriore esumazione e la traslazione al Parco Vergiliano a Piedigrotta. Ulteriori proposte su test di Dna sono state anche di recente negate dai discendenti.