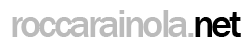Non era un biopic nel senso più tradizionale nel termine. Non era nemmeno un’opera simbolista e gratuitamente divergente: per come si presentava era chiaro solo quello che non era. Ovvero, tutto quello che c’era sempre stato.
Stile, scelte, esplorazioni: il Bob Dylan di Todd Haynes
Quarantacinque anni di carriera e di vita (fino ad allora), di incontri, di stili, fasi e reinvenzioni: esageratamente da dire, per un solo Bob Dylan. Che diventò sei personaggi diversi, di età diverse. Finché Bob Dylan non fu praticamente mai nominato: tra pseudonimi credibili, differenti declinazioni e molteplici anime, compariva realmente soltanto nel finale, in un footage di repertorio. Come a dire: io non sono qui, in quello che avete visto, ma alla fine arrivo. Ci sono sempre stato.
Sei personaggi, tutti lui, tutti altro da lui: «Poeta. profeta. Fuorilegge. Imbroglione. Star di elettricità». Queste le forme dell’artista maturo. Ma si cominciava da un undicenne afroamericano, da quell’anima giovane e sfrontata che ama (e vorrebbe essere, ed è) Woody Guthrie, la cui velleità da menestrello viaggia su carri merci fuori tempo.
Poi un cast da uscir di senno: Christian Bale (che ritrovava Haynes a nove anni da Velvet Goldmine) nei abiti Jack Rollins, alter-ego dylaniano degli anni di The Freewheelin’ Bob Dylan e The Times They Are a-Changing. Heath Ledger, ad interpretare l’attore che interpreta Jack Rollins in un biopic su di lui, matrioska di interpretazioni delle interpretazioni, di maschere della maschera. Una superlativa Cate Blanchett a fare Jude Quinn, traslitterazione della contestatissima svolta elettrica dal folk acustico: a ritirare la Coppa Volpi a Venezia per l’attrice australiana fu Heath Ledger, una delle sue ultime uscite a pochi mesi dalla scomparsa. Richard Gere come il fuorilegge Billy the Kid, a evocare l’escursione cinematografica del cantautore per Sam Peckinpah, l’omerico ritorno al luogo di origine che si chiama Enigma, la riconversione con una identità consumata in una fuga perenne. E ancora Ben Whishaw, l’Arthur Rimbaud come ispirazione giovanile, poeta simbolista e anima citazionista sotto investigazione.
Ma anche un parterre di personaggi secondari, compagni di viaggio da far tremare i polsi: Charlotte Gainsbourg, tormentata e dolcissima moglie ispirata a Suze Rotolo. Michelle Williams, modella che alludeva a Edie Sedgwick. Julianne Moore, trasposizione di Joan Baez. Bruce Greenwood, che incarnava la ferocia della critica, nonché il bersagliato Mr Jones di Ballad of a Thin Man.
I’m Not There: il Bob Dylan che non c’era, oppure sì
«Anche il fantasma era più dell’uomo», proferiva la voce fuori campo all’inizio del film, ed era la dichiarazione d’intenti di un’allegoria senza sosta, passando dagli stratagemmi del mockumentary a quelli dell’elegia, di un lavoro ambizioso in cui forma e sostanza furono la stessa cosa. «Nei cinquant’anni di sua lunga percorrenza nel mondo della musica e della poesia, Bob Dylan ha fatto del suo la parte migliore per non raccontarci mai esattamente quello che ha combinato nella vita», ha detto Ernesto Assante a proposito del film. «Sappiamo dove è nato, sappiamo qualcosa che gli è capitato in quel curioso pezzo di vita in cui non si è manifestato come Bob Dylan ma era ancora Robert Zimmerman. Ha avuto infiniti nomi. Ma alla fine la domanda che ci poniamo è: perché dovremmo davvero sapere chi è Bob Dylan?»